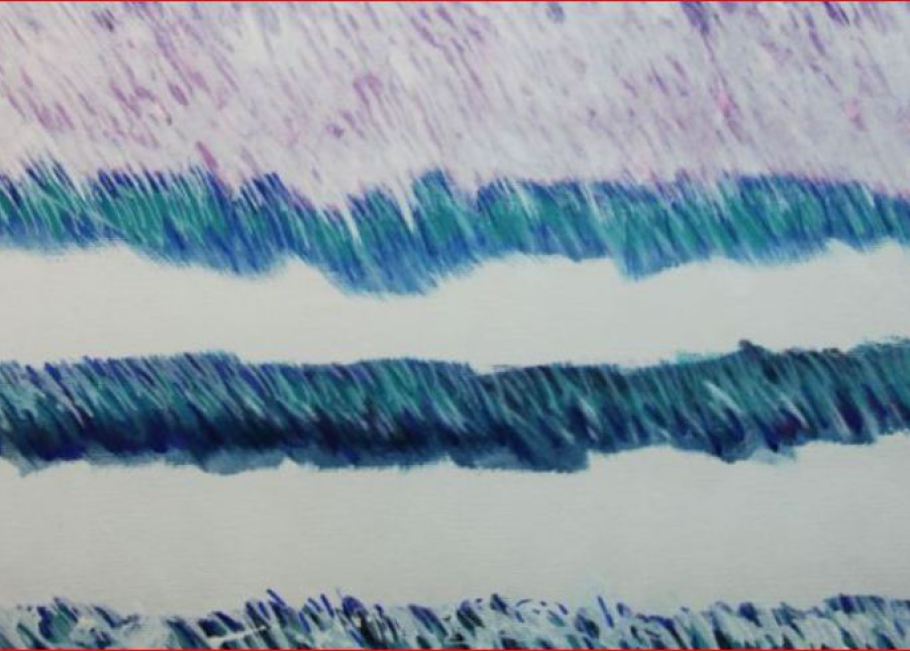
Se l’equilibrio è nella tensione: il valore del dubbio, il significato di una contraddizione, il ritmo dell’incostanza.
Un tentativo di riordino può farsi scrivendo.
Scrivere di se stessi non è facile ma l’esplorazione del passato si può tentare. Lo faccio per estrarne un significato possibile, un filo conduttore tra le vicende che possa aiutarmi ad assecondare il karma ed agevolare un futuro accettabile, al netto dell’imprevedibile e dell’inevitabile.
Quanto spazio abbia occupato l’arte nella mia vita, quanto nella mente o quanto ne avrebbe potuto occupare, non so dirlo. Tuttavia, so per certo che essa mi ha tanto aiutato nel percorso di crescita e formazione. È vero: ha dovuto convivere con tanti altri interessi e forse proprio la curiosità sperimentale verso tutto mi ha sollecitato a seguire gli insegnamenti di mia madre. Mi faceva notare che il tetto delle case che disegnavo da bambino era sbagliato. Cominciavano così le sue prime lezioni sulla prospettiva che avrei poi applicato al carrello porta televisore. I quattro piedi, come quelli del tavolo e della sedia erano per me della stessa lunghezza; ma quando andavo a rappresentare su un piano, cioè sul foglio di carta, un oggetto che nello spazio si collocava con una dimensione in più, la profondità, ecco che magicamente i piedi posteriori diventavano più corti. Per questo mi fu poi facile capire perché i cipressi di -Davanti a San Guido-, andando incontro a Carducci in treno, erano più grandi quando più prossimi erano al poeta, più piccoli quando erano lontani da lui. Così li disegnava il prof. Domenico Longo alle medie.
Dalla forma al colore il passo fu immediato e, come per la prospettiva, capii che il bianco delle case di Peschici, lontane e sulla rupe, era totale mentre quello del camice del salumiere, dietro il bancone, e quindi a me vicino, talvolta si perdeva sul colletto liso e in alcuni punti cedeva all’unto della mortadella.
Intanto mi eccitava il duplicatore a spirito nella copisteria della stazione ferroviaria di Foggia per i “dispacci” da consegnare al capotreno e al macchinista. Erano gli ordini da rispettare sul percorso: accelerazioni e frenate, cautele, fischi, semafori, lavori in corso, fermate di servizio, incroci, scambi, arrivi e ripartenze. Così mi spiegava mio papà capostazione riproducendo, sul “plastico” del trenino sotto l’albero di Natale, quello che veramente accadeva sul Tavoliere di Puglia. Mi piacevano i timbri e la magia della replica del segno, l’odore dell’inchiostro, quello dell’olio bruciato dai freni sul primo binario, gli sbuffi della vaporiera della locomotiva sul sesto, il treno per Manfredonia.
Il giornalino scolastico soddisfaceva la mia ansia sperimentale dei caratteri mobili, del normografo dei geometri, del ricalco sugli acetati o sul vetro della finestra, degli adesivi per le copie eliografiche. Stavo benissimo e stavo malissimo: proiettavo cartoline sui muri di casa con l’episcopio-scatola di scarpe-lente alla Standa attaccata al tubo della carta igienica con la cera di candela e sognavo sagome di polistirolo per il presepe tagliate con il seghetto. Stavo benissimo per quello che facevo, il galvanometro con le bobine dei fili elettrici dei “pisellini”, e stavo malissimo perché volevo perfezionare il telefono bi-banda con i barattoli di salsa e il filo di nylon. E dipingevo, usando la cassetta dei colori ad olio, tremila lire, e vendevo tele “messicane” al bottegone in cambio di merce che nascondevo nel box. Mamma mi dava i soldi per andare a comprare lo zucchero e io le portavo quello che avevo ottenuto e nascosto in cambio dei primi quadri. Mia madre si arrabbiò col bottegaio: - Tu piazzi a mio figlio quello che io non ti chiedo-. –Ma no, è lui che prende ciò che vuole e mi paga con i quadri, non con i soldi-. Svelato l’arcano, apprezzato il valore del baratto, la mia carriera artistica subì tuttavia una prima battuta d’arresto fino a quando non intervennero gli zii collezionisti prima e i turisti sul Gargano poi. Partiva l’epopea del giovanissimo pittore un po’ matto sul paracadute comprato alle pezze americane e steso a terra e i fogli di Murillo azzurri. Se facevo il normale, la gente si limitava a fermarsi; se invece Orietta zittiva i curiosi intorno, turisti di agosto a frotte, perché sotto il mio sombrero non mi innervosissi, interrompendo i disegni in china bianca nello show serale, allora fioccavano le mille lire e più; una sera facemmo quindicimila lire; lo stipendio di mio padre non arrivava a centomila lire. Il gioco era facile: al primo che chiedeva il prezzo del disegno in itinere, io stracciavo irritato il capolavoro in via di completamento. Mi alzavo e abbandonavo irritato la scena. I soldi fanno schifo al maestro, approfittate ora che non c’è. Orietta incassava stupefatta.
Ero già sul versante della contaminazione? Decideva la gente quel che dovevo dipingere ? Era iniziata la truffa della suggestione popolare? Precorrevo i tempi delle aste televisive? So solo che se tenevo i miei disegni sotto il letto, non me li vedeva nessuno; se li mostravo in anonima sala ne vendevo qualcuno, se alla mia mostra arrivavo a cavallo con poncho e rayban, allora ero il maestro e i miei quadri un investimento. La credibilità passa per lo stupore.
Al mattino, sotto gli archi di cala San Nicola, nella villa di mio zio, mi piegavo alle leggi del mercato e mi prostituivo con i primi ritratti ai bambini ricchi. Poi segretamente liberavo le mani e la mente e mi davo agli esperimenti, quasi sempre finiti a picconate sulle tavole dipinte con ansia tradita dal risultato di indigeribili croste. Mia zia si accorse del travaglio, mi distraeva e mi sottraeva “testimonianze” che dopo cinquant’anni sono nascoste negli armadi dei sopravvissuti.
Osservando i reperti di allora, piuttosto sorrido alle tempere ordinate che imitavano Dario Lombardi e le sue marine eleganti e di effetto.
Raggiunsi Mario Lupo a Grottammare e nel suo castello studio gli chiesi io chi fossi e cosa dovevo fare, posto che mi ero perso tra personalità diverse e contrastanti. Mi regalò una bella incisione, tuttora conservata dalla mia prima moglie che nulla sapendo della obliterazione del valore in caso di cancellazione di dediche, disinvoltamente ha abraso la storicizzazione a matita dell’episodio, bagnato da ottimo Porto, offertomi dall’esperto pittore compiaciuto dei miei adolescenziali indugi.
Feci lo stesso con il critico d’arte della Gazzetta del Mezzogiorno Pietro Marino, e poi con Remo Brindisi, Manlio Bacosi , Alfredo Bortoluzzi e Romano Conversano. Volevo davvero un sostegno psicologico, un parere tecnico e sviscerato, volevo un aiuto, una indicazione, un suggerimento, una direzione o la sollecitazione ad un gesto di coraggio ? Macchè ! Davvero non sapevo chi fossi. Oggi lo so ?
La direzione me la dette uno che i miei quadri non poteva vederli, Pasquale Soccio che evocò Montale:- Non sono che favilla d’un tirso. Bene lo so: bruciare, questo, non altro, è il mio significato- e mi additò Picasso:- Io non cerco, trovo- .
La conferma me la regalò Lucio Dalla: il tuo equilibrio è nella tensione, la tua certezza è nel dubbio, il tuo significato è nella contraddizione, i tuoi tempi nella incostanza. -Ti sento un vero amico perché ogni istante di vicinanza è umana energia allo stato puro.- A differenza di Pasquale Soccio, morì senza avvertirmi che sarebbe morto e da allora non mi ha più comprato quadri.
Sono nato a Foggia il 23 giugno del 1953, secondo di tre fratelli (da sinistra William e Antonio), in via Nicola Parisi, 19, in adiacenza a Piazza XX Settembre da Michele Lecci capostazione ed Elsa Longo, insegnante, prima impiegata e poi casaliga.
Con i miei fratelli William, a sinistra, e Antonio, al centro, deceduto nel maggio del 2021 e mia madre, deceduta nel gennaio del 2016. Mio padre è deceduto nell'agosto del 1982.
parliamone

